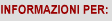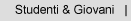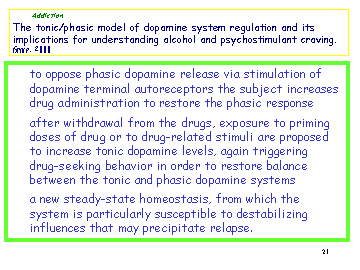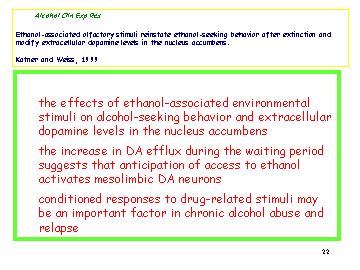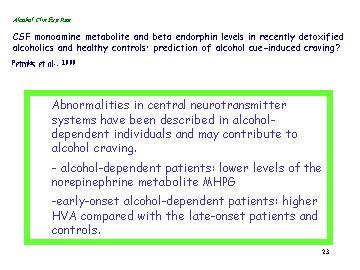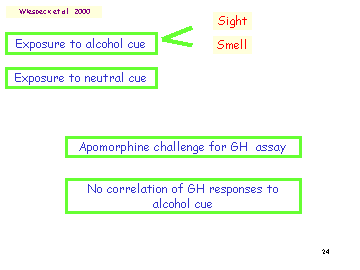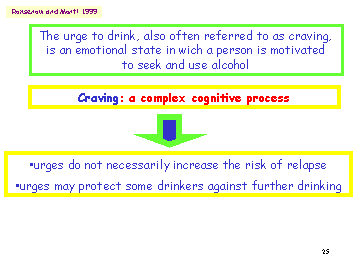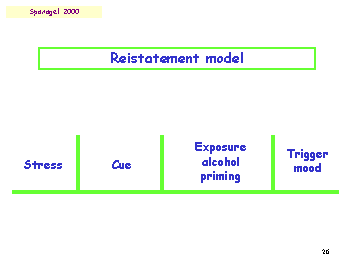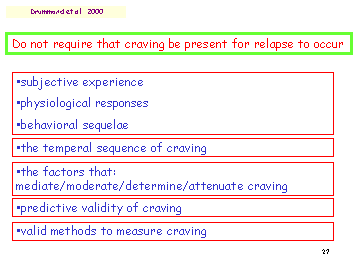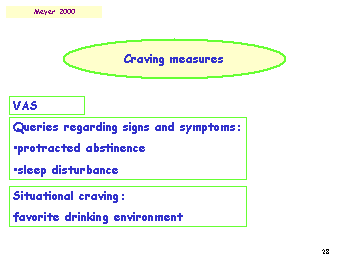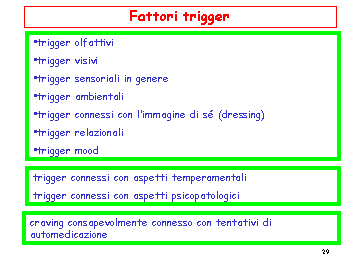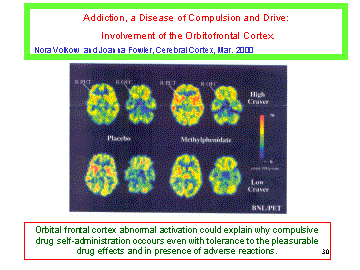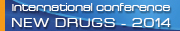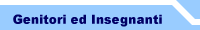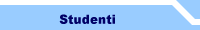|
Durante la astensione dalle sostanze l'effetto
priming della esposizione alla droga o all'alcool incrementerebbe di nuovo i
livelli tonici di dopamina, con la necessità di riutilizzare le sostanze per
ritornare alla condizione "fasica".
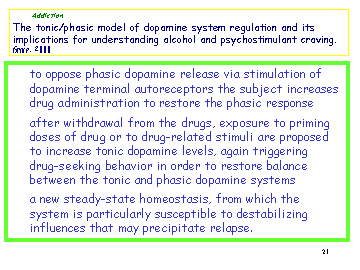
Fig 21
Questo delicato equilibrio tra fase tonica e fasica della secrezione della dopamina sarebbe
comunque molto precario, con un rischio di scompenso facile alla ricaduta
(Grace, 2000).
In ogni caso, è stato dimostrato che i neuroni mesolimbici dopaminergici sono
attivati già nella fase che anticipa l'assunzione di alcool, verosimilmente a
supporto della percezione della urgenza di bere, del tutto precedente rispetto
alla assunzione di etanolo (Katner and Weiss, 1999).
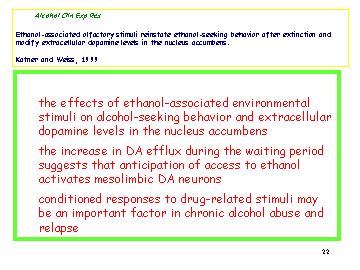
Fig 22
.
Il craving sarebbe dunque espressione, dal punto di vista biologico, di una interazione tra questa
mobilitazione delle vie dopaminergiche indotta dalla sostanza e le alterazioni
delle monoamine connesse con la vulnerabilità: negli alcoolisti infatti sono
stati rilevati, in relazione con il craving, una ridotta concentrazione di MHPG,
catabolita delle catecolamine, e una elevata concentrazione di acido
omovanillico (HVA), espressione del turnover della dopamina (Petrakis et al.,1999).
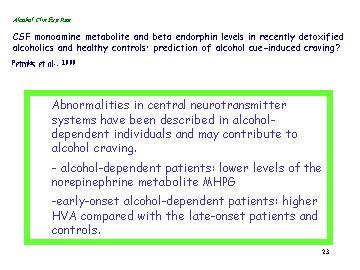
Fig 23
In contrasto con queste evidenze, il test alla apomorfina, capace di
valutare, attraverso le risposte in GH, la funzione dopaminergica, non avrebbe
mostrato correlazioni tra funzione della dopamina e livelli di craving (Wiesbeck et al., 2000).
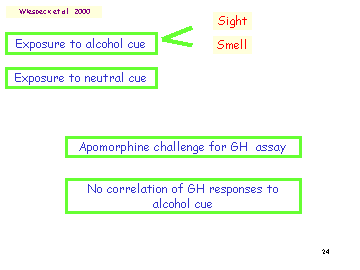
Fig 24
Recenti studi sottolineano come il craving, considerato un processo cognitivo
complesso che include l'urgenza di impiegare la sostanza e la consapevolezza del
rischio, non è obbligatoriamente connesso con i rischi della ricaduta: anzi al
contrario in alcuni casi lo stato conflittuale interno che corrisponde al
craving può rivelarsi addirittura protettivo rispetto al reale impiego della
sostanza. Questa condizione di conflitto indurrebbe a un allarme nei confronti
dell'abuso di droghe (Rohsenow and Monti, 1999).
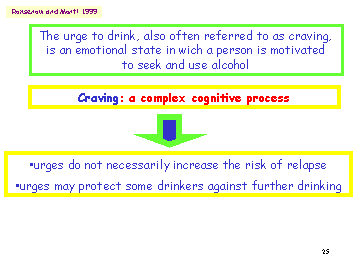
Fig 25
Diversi modelli e diverse vie possono avviare il processo della ricaduta
evocando il craving: sebbene l'esposizione ai cue, lo stress, l'effetto priming
del contatto con la sostanza, le condizioni del tono dell'umore, tutte queste
dimensioni concorrano a incrementare il rischio della ricaduta (Spanagel, 2000),
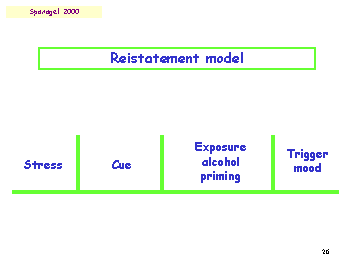
Fig 26
appare sempre più evidente comunque che il verificarsi della ricaduta
non è strettamente collegato e obbligatoriamente correlato all'entità del
craving (Drummond et al., 2000).
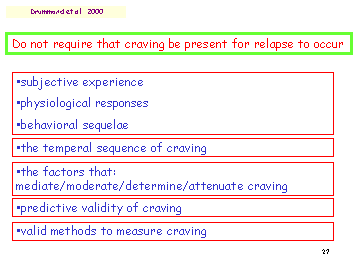
Fig 27
Per ciò che concerne le misurazioni del craving, è nota la semplice metodologia
che impiega un analogo visuale di 100 mm; l'urgenza di impiegare la sostanza può
anche essere misurata attraverso il persistere dei disturbi astinenziali, in
particolare l'insonnia. Si parla di "situational craving" e cioè una
condizione in cui le misure del craving dipendono dalla esposizione a fattori
ambientali: così anche l'esposizione sperimentale ai cue dovrebbe tener conto
degli aspetti connessi con specifiche "situazioni" ambientali in cui
l'elemento trigger è inserito (Meyer, 2000).
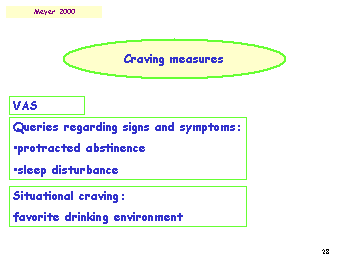
Fig 28
Le varie possibili tipologie di fattori trigger sono elencate nella seguente tabella.
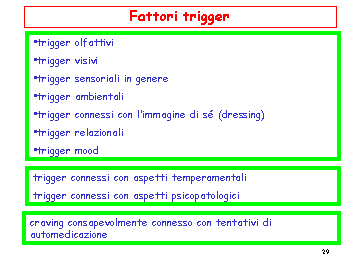
Fig 29
Emergono diverse vie sensoriali, strategie relazionali e
fattori intrapsichici come possibili scatenanti del craving.
Da ultimo occorre menzionare importanti studi di brain imaging che tentano di
rispondere a un interrogativo sul craving rimasto ancora senza soluzioni: perchè
dopo tanti anni di tossicodipendenza, al momento in cui la tolleranza ha
vanificato gli effetti gratificanti della sostanza, e nella fase in cui
prevalgono gli effetti avversi, il soggetto tossicodipendente continua nel
comportamento compulsivo nei confronti della droga?
La risposta sembra essere stata intuita attraverso gli studi di Nora Volkow che
mostrano una abnorme attivazione del "drive", cioè il nucleo
orbito-frontale nella corteccia cerebrale, con una autonomizzazione rispetto ai
nomali imput provenienti dal sistema della gratificazione. Il nucleo che appunto
sintetizza le afferenze al fine di produrre decisioni comportamentali e risente
dei meccanismi condizionati diverrebbe iperfunzionante e incontrollabile:
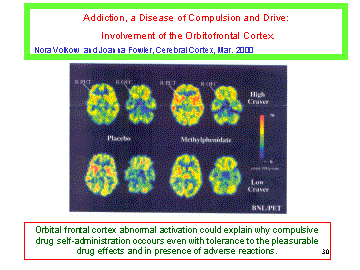
Fig 30
(Volkow and Fowler, 2000) mostra tale iperattività del nucleo
orbito-frontale in correlazione con elevati livelli di craving.
|