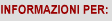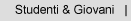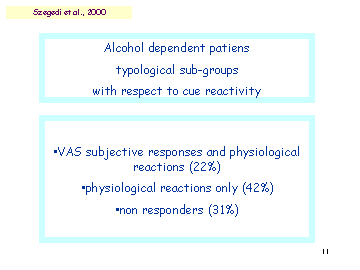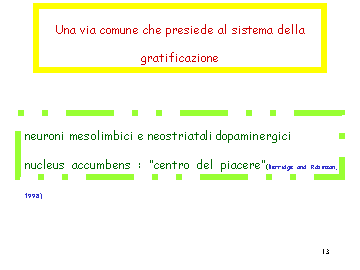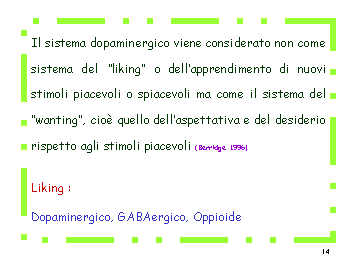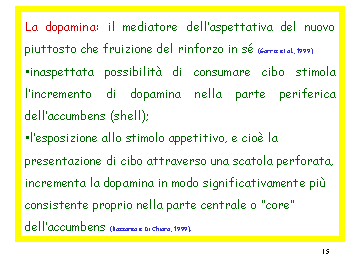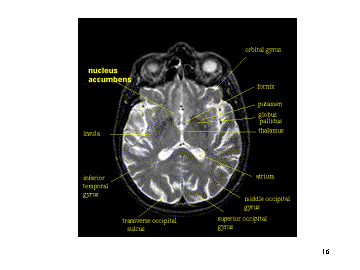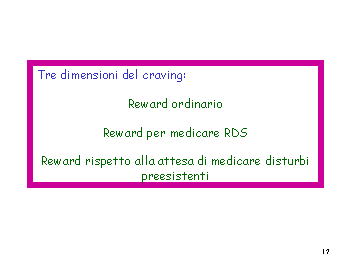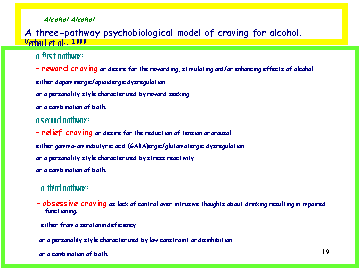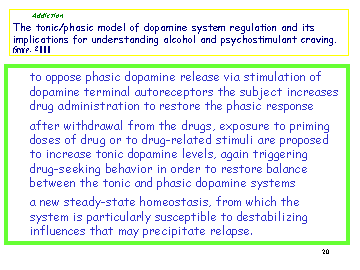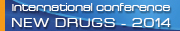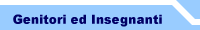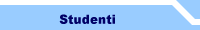|
All'interno di una generica vulnerabilità per la dipendenza da sostanze si può
arrivare a distinguere tipologie di soggetti dipendenti in relazione alla
risposta agli stimoli "cue": alcuni soggetti infatti, il 22% di quelli
studiati, mostrano sia una reazione soggettiva, con valutazione rilevabile ad un
test analogo visuale (VAS), che una reazione fisiologica agli stimoli
condizionati. Altri, il 42%, attivano soltanto risposte fisiologiche, senza una
percezione soggettiva e consapevole di craving. Una restante porzione dei
soggetti inclusi nello studio, oltre il 30%, non mostra alcuna reazione ai cue
(Szegedi et al., 2000). Evidentemente condizioni psicobiologiche specifiche si
associano a tali difformi reazioni in relazione al craving evocato dagli stimoli trigger.
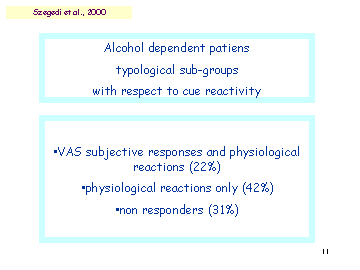
Fig. 11
Per ciò che concerne gli elementi biologici che possono sostenere la percezione
del craving occorre distinguere le condizioni evocate dai disturbi astinenziali
da quelle invece prodotte dall'esposizione a elementi trigger. Le prime, quelle
correlate con l'astinenza, corrispondono a un ridotto tono dopaminergico a
livello del sistema della gratificazione, fatto estensibile a tutte le sostanze
d'abuso; un deficit serotoninergico è stato rilevato in relazione alla
interruzione della assunzione di cocaina, insieme con il "derangement"
di tutte le altre monoamine cerebrali (Haney et al., in press); l'elevato tono
noradrenergico e del sistema NMDA è relativo all'astinenza da eroina e da
alcool; il deficit GABAergico sembra essere presente nella sospensione
dell'etanolo (Drummond et al., 2000).

Fig. 12
Al contrario il craving connesso
con l'esposizione ai "cue" presenta una natura neurobiologica del
tutto diversa: la secrezione di dopamina sarebbe associata proprio alla
aspettativa della gratificazione. Nel nucleo ventrale del pallido, cioè
nell'accumbens, si verificherebbe un incremento di dopamina durante la fruizione
delle gratificazioni, a livello dello shell, nel guscio che fa da contorno a
questo nucleo. L'aspettativa della fruizione delle gratificazioni, invece, lo
stato di urgenza e desiderio (il craving) che precede la fruizione di un oggetto
piacevole, appaiono essere correlati con un incremento di dopamina a livello del
core dell'accumbens (Bassareo and Di Chiara, 1999; Garris et al., 1999). La
dopamina può dunque essere considerata il neurotrasmettitore del
"wanting", del craving appunto, del "sabato del villaggio",
dell'attesa di un piacere che deve ancora essere colto. I neurotrasmettitori del
"liking", cioè della fruizione delle gratificazioni in sè, sembrano
essere i peptici oppioidi e il GABA, evidentemente articolati in un delicato
equilibrio con la dopamina (Berridge, 1996).
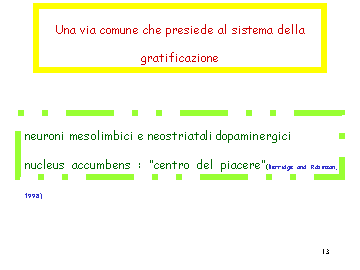
Fig. 13
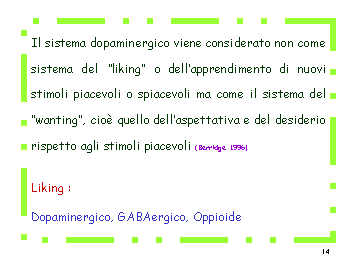
Fig. 14
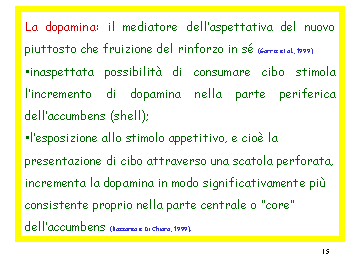
Fig. 15
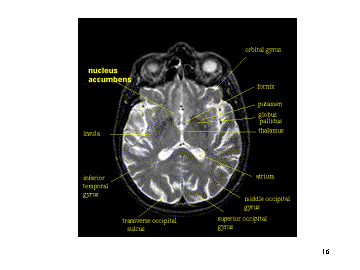
Fig. 16
Se si considerano le interazioni tra aspetti biologici e elementi
comportamentali, il craving può essere visto dal punto di vista della sostanza
psicoattiva, e cioè dal livello di capacità addittiva della sostanza: in questo
caso il craving sarà sostenuto da alterazioni biologiche indotte relativamente
agli effetti gratificanti della droga, o all'astinenza dalla stessa. In un
secondo caso, il craving sarà maggiormente fondato sulla necessità di
auto-medicare quella che Blum chiama Reward Deficiency Syndrome (Blum et al.,
2000): questa forma di craving è maggiormente legata all'individuo, e non alla
sostanza gratificante in sè: l'urgenza di usare l'alcool o la droga è connessa,
in questo caso, ad alterazioni biologiche preesistenti la storia di droga,
determinate geneticamente e da precocissime interferenze ambientali (Cloninger
et al., 1988; Galvin et al., 1991). Una terza, e più complicata situazione, vede
il craving sostenuto dal desiderio di curare, o anestetizzare sul nascere, o
distrarre l'attenzione, rispetto a problematiche di carattere psicopatologico
che in qualche modo hanno costituito gli elementi causali dello sviluppo del
disturbo da uso di sostanze. Questa ultima forma di craving, più difficile da
distinguere da un aspecifico distress che si verifica al momento della
disassuefazione, può essere biologicamente supportata dalle diverse alterazioni
che la psichiatria biologica ha sinora evidenziato in associazione con i
disturbi psichiatrici (Horner and Scheibe 1997).
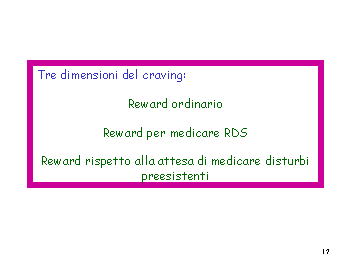
Fig. 17
Ad esempio, la disforia alla sospensione della cocaina, così connessa con i livelli di craving
per la cocaina stessa, può essere legata non al deficit serotoninergico indotto
dalla sostanza per sè, ma alla disfunzione serotoninergica relativa alla
depressione che cercava nella droga un tentativo di auto-cura.
Riguardo alle metodologie sperimentali che hanno tentato di investigare
l'innesco del craving per l'alcool, precocemente durante l'astensione dalla
sostanza in soggetti alcoolisti, ci si è posto il problema di quali elementi
siano veramente capaci di far partire il processo condizionato che si traduce
nell'urgenza di bere: se sia prevalente il ruolo dell'esposizione alle bevande
alcoliche in sè, oppure le immagini "cue" che richiamano l'alcool,
oppure ancora il richiamo a elementi autobiografici della storia del paziente
che evocano esperienze di craving (Weinstein et al., 1998). Tutte e tre queste
condizioni si sono rivelate capaci di indurre un certo arousal autonomico con
incremento della pressione sistolica e della frequenza cardiaca, associato in
tutti i tre i casi con elevazione del craving.

Fig. 18
Anche attraverso questa metodologia sperimentale emerge dunque che l'urgenza di impiegare le sostanze
può essere sostenuta a partire da vie differenti, non obbligatoriamente dalla
concreta esposizione all'alcool e alle droghe.
Un interessante modello psico-biologico di analisi del craving identifica tre
possibili vie per l'instaurarsi dello stesso, in relazione alle aspettative che
ne sostengono l'intensità, ai neurotrasmettitori coinvolti e allo stile di
personalità correlato.
- Una prima forma di craving è detto "reward craving": la via che lo
attiva è appunto il desiderio della gratificazione. La disregolazione del
sistema dopaminergico/oppioide e una personalità reward-seeking (novelty,
sensation- seeking) ne sarebbero responsabili.
- La seconda forma di craving, o "relief craving", è sostenuta dal
desiderio di ridurre la tensione o lo stato di arousal. Le vie neuroendocrine
coinvolte, in questo caso, comprenderebbero un disequilibrio tra sistema
GABAergico e recettori NMDA. La personalità più facile a presentare questa forma
di craving sarebbe caratterizzata da una elevata reattività allo stress.
- Da ultimo, la terza forma di craving viene definita "obsessive
craving", cioè la mancanza di controllo nei confronti del pensiero
intrusivo della sostanza. La disfunzione neuroendocrina associata a questa terza
condizione sarebbe un deficit del sistema della serotonina, in correlazione con
un tipo di personalità con difficoltà del controllo degli impulsi (Verheul et al., 1999).
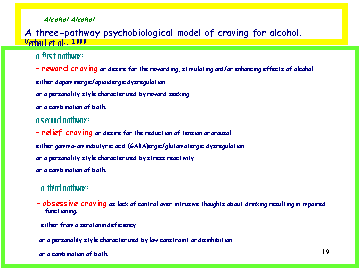
Fig. 19
Le alterazioni del sistema dopaminergico atte a spiegare il craving appaiono più
complesse di quanto si sia sino ad oggi immaginato. Secondo alcuni la risposta
della dopamina alle droghe a livello del nucleus accumbens avrebbe un andamento
bifasico: lo spike acuto di dopamina, da un lato, sarebbe associato all'effetto
gratificante (effetto fasico); dall'altro, l'effetto tonico delle droghe,
associato al craving, comporterebbe un incremento di dopamina extracellulare,
non sufficiente a stimolare i recettori post-sinaptici, ma abbastanza elevato da
agire sugli auto-recettori presinaptici con il ruolo di inibire l'ulteriore
release di dopamina (Grace, 2000).
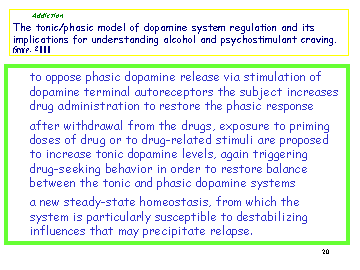
Fig. 20
Il soggetto dipendente tenta di
superare l'inibizione ottenuta nella fase tonica incrementando i dosaggi della
droga, al fine di reinstaurare la fase fasica, con nuovi spike gratificanti del
release di dopamina (Grace 2000).
|