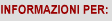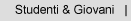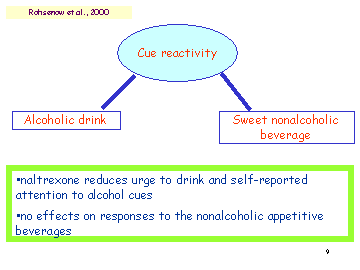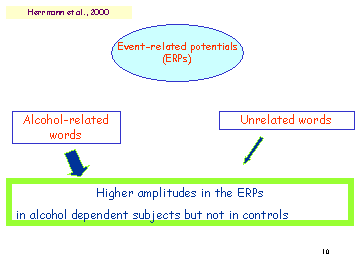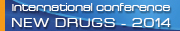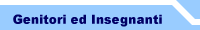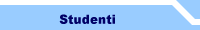|
Il craving è il desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, per un cibo o
per qualunque altro oggetto-comportamento gratificante: questo desiderio
impulsivo sostiene il comportamento "addittivo" e la compulsione
finalizzati a fruire dell'oggetto di desiderio. Ad esempio il craving per
l'alcool può essere definito da un punto di vista linguistico "urgenza di
bere", cioè la tensione a consumare la sostanza, il pensiero ossessivo
ricorrente del bere, sino alla perdita del controllo dei propri impulsi nei
confronti delle bevande alcoliche.

Fig. 1
Craving dunque come "urge to drink" innescato dalla presenza di
bevande alcoliche che scatenerebbero, prima ancora di essere assunte, un
desiderio incontrollabile nei soggetti vulnerabili. Il craving non è
necessariamente connesso, quando è indotto dalla esposizione alle bevande
alcoliche, alla possibilità di predire la ripresa del bere: al contrario
l'urgenza di bere appare predittiva del maggior impiego di bevande alcoliche,
durante i mesi successivi, quando è prodotta dalla esposizione a condizioni
relazionali sperimentalmente indotte e al "role play" (Monti et al.,2000).

Fig. 2
Addirittura è stato verificato che le misure della
consapevolezza e dell'attenzione rispetto agli elementi scatenanti il craving
possono essere inversamente correlate con l'entità reale del consumo di sostanze.
Il craving viene definito da altri l'esperienza soggettiva dello stato
motivazionale direttamente responsabile del consumo di sostanze in soggetti
dipendenti; una sorta di percezione interna dei livelli di compulsione nei
confronti dell'alcool e delle droghe. Il craving sarebbe prontamente stimolato
da fattori previamente associati con la sostanza, elementi capaci di svolgere un
ruolo "trigger", cioè "grilletto", che innescano con un
meccanismo di condizionamento, e per associazione di idee, il desiderio della
gratificazione ottenuta chimicamente (Tiffany and Conklin, 2000).

Fig. 3
Due le forme di craving distinte dal punto di vista delle aspettative del
paziente: da un lato la preoccupazione di assumere la sostanza per evitare
l'astinenza che viene definita "craving negativo", dall'altro la
compulsione nei confronti della sostanza sostenuta dall'aspettativa di una
incentivazione, di una gratificazione. In questo caso la ricerca di un
"reward" produrrebbe un "craving positivo". (Tiffany and Conklin, 2000).

Fig. 4
Non semplice da spiegare la relazione tra craving e impiego addittivo della
sostanza: infatti la semplice assunzione delle sostanze psicoattive che segue i
ritmi e le modalità del comportamento addittivo è regolata da un processo
automatico; al contrario il craving comporta l'attivazione di un meccanismo
cognitivo che non corrisponde ad un processo automatico. L'urgenza di utilizzare
la sostanza (craving) è connessa piuttosto con un conflitto nell'ambito
cognitivo tra la motivazione all'assunzione dell'alcool o della droga e la
consapevolezza del rischio che ne deriva: in quest'ottica dunque il craving
diviene funzione di diversi fattori che interagiscono in un mutevole equilibrio
con il mondo intrapsichico e con le interferenze ambientali. Tra questi fattori,
primo tra tutti il desiderio della sostanza sostenuto dall'esposizione a stimoli
condizionanti (cue), dallo stress e da condizioni a rischio del tono dell'umore
(trigger mood) mantiene elevati livelli di craving; ad interferire con questo
fattore di base viene la capacità di adattamento legata ai tratti
temperamentali, alle caratteristiche psicologiche e ai disturbi psichiatrici,
nonchè la consapevolezza del rischio connessa invece con la storia individuale,
i fattori culturali, ambientali e relazionali (Monti et al., 2000).

Fig. 5
Il craving rappresenta il desiderio per gli effetti della sostanza di cui il
soggetto ha già fatto esperienza e che sono risultati gratificanti: elementi
portanti a supporto del craving sarebbero l'impiego eccessivo della sostanza, in
particolare durante l'astinenza dopo un periodo di dipendenza; il cambiamento
della soglia della gratificazione a livello del Sistema Nervoso Centrale, con
stati affettivi negativi, e i "rinforzi" indotti a partire da
meccanismi condizionati (Koob, 2000).

Fig. 6
Elemento più importanti del craving nel predire l'impiego delle sostanze è il
livello di salivazione durante l'esposizione ai cue, alle immagini trigger
(Monti et al., 2000):

Fig. 7
rispetto alla reattività di fronte a immagini
"cue", capaci di suscitare un certo livello di craving in laboratorio
umano, il desiderio impulsivo per la sostanza registrato sul campo, e cioè in
condizioni cliniche ordinarie, è maggiormente correlato con la reale assunzione
della sostanza e l'intensità della dipendenza. D'altra parte non sempre si è
verificata una correlazione stretta tra craving misurato in condizioni di
laboratorio e craving sul campo (Litt et al., 2000).

Fig. 8
Il rilievo di basi biologiche per il craving è stato documentato in molti modi:
ad esempio la reattività alla esposizione agli stimoli condizionati (cue) induce
una incrementata urgenza di bere nei soggetti alcoolisti, coinvolgendo sia le
bevande alcoliche che gli analcolici: il naltrexone, antagonista dei recettori
oppioidi, sembra ridurre il desiderio delle bevande alcoliche, senza interferire
con il craving per le bevande analcoliche, indicando una specificità del ruolo
del sistema dei peptici oppioidi nel craving per l'etanolo e nelle precedenti
esperienze con l'alcool (Rohsenow et al., 2000).
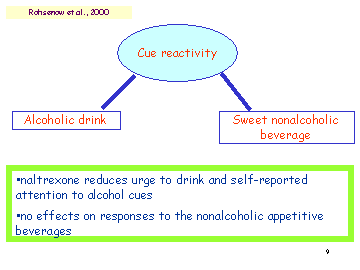
Fig. 9
La vulnerabilità dell'individuo, e cioè la predisposizione psicobiologica a
sviluppare la dipendenza, appare giocare un ruolo chiave nella percezione del
craving: parole (cioè termini in senso linguistico) alcool-correlate assumevano
la funzione di elementi scatenanti, di "cue", più nei soggetti
alcoolisti che nei soggetti controllo, mostrando la capacità di indurre
potenziali EEG eventi-correlati più ampi nei soggetti affetti dalla dipendenza
(Herrman et al., 2000).
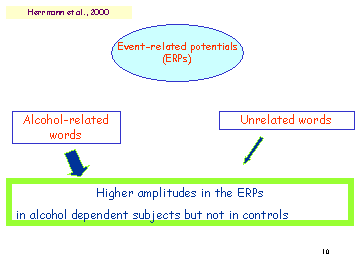
Fig. 10
|